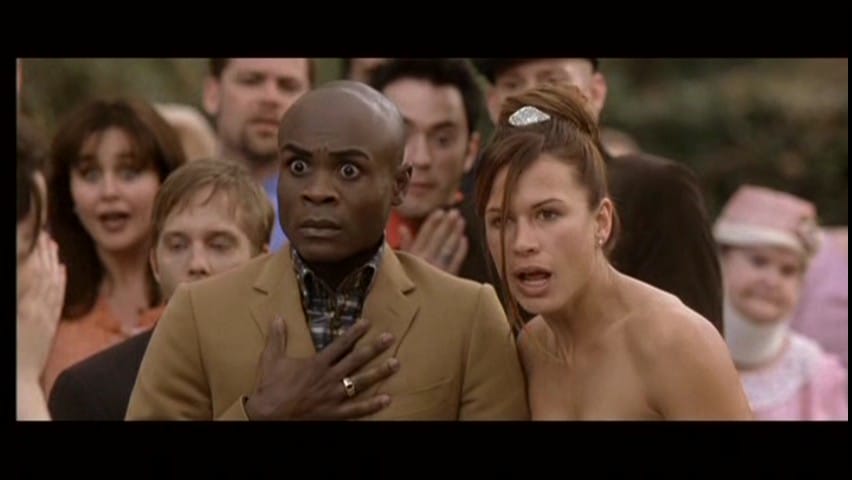Nel grande pantheon del cinema moderno, poche figure occupano uno spazio singolare e amorevolmente cesellato come Guillermo del Toro. È un regista, un autore, un artista, ma soprattutto è un alchimista. Per oltre tre decenni ha praticato una forma unica di alchimia cinematografica, prendendo quella che alcuni potrebbero definire “materia vile” — mostri, fantasmi, insetti e gli orpelli dell’horror — e trasmutandola in oro narrativo. Il suo lavoro è la testimonianza di una convinzione profonda e incrollabile: che i mostri siano i “santi patroni dell’imperfezione” e che all’interno del grottesco si nasconda una bellezza unica e poetica.
La sua carriera non è una semplice progressione dall’horror a basso budget al prestigio di Hollywood, ma un progetto coerente e lungo una vita per costruire un gabinetto delle curiosità cinematografico. Ogni film è un nuovo cassetto in questo mobile, che rivela un mondo meticolosamente progettato in cui le fiabe si scontrano con la brutale macchina della storia e dove i personaggi più umani hanno spesso corna, branchie o cuori a orologeria. Questa visione incrollabile lo ha portato alle vette più alte del settore, facendogli vincere i Premi Oscar per il Miglior Regista e il Miglior Film per un’opera sull’amore di una donna muta per un dio fluviale, e un altro per il Miglior Film d’Animazione per una favola in stop-motion su un burattino di legno nell’Italia fascista. Il viaggio di Guillermo del Toro è la storia di un regista che non ha cambiato la sua visione per ottenere l’approvazione di Hollywood ma che, con pura maestria e convinzione, ha fatto in modo che Hollywood apprezzasse finalmente la profonda e mostruosa visione che ha sempre custodito.
Un’infanzia forgiata nell’ombra e nella fede
La materia prima dell’intera visione artistica di del Toro è stata estratta dalle strade e dalle case della sua nativa Guadalajara, in Messico, dove è nato il 9 ottobre 1964. La sua giovinezza è stata un crogiolo di influenze profonde e spesso contraddittorie. È cresciuto in una famiglia cattolica severa e devota, presieduta da sua nonna, una donna la cui fede era tanto una fonte di ricca iconografia quanto di profondo terrore. Lei vedeva la sua nascente fascinazione per il fantasy e l’horror non come una scintilla creativa, ma come una malattia spirituale. Disapprovando i suoi disegni di mostri e demoni, sottopose il giovane a due esorcismi, gettandogli addosso acqua santa nel tentativo di purificare la sua anima. Come ulteriore forma di penitenza, gli metteva dei tappi di metallo nelle scarpe perché gli insanguinassero i piedi, una cruda manifestazione fisica del senso di colpa religioso.
Questo cattolicesimo morboso si rispecchiava nella realtà senza filtri della città stessa. Del Toro ha parlato della sua precoce e ripetuta esposizione alla morte, conservando vividi ricordi di cadaveri reali visti negli obitori, nelle catacombe delle chiese e per strada dopo incidenti o atti di violenza. Questo ambiente, dove il sacro e il profano erano in costante e viscerale dialogo, ha plasmato una mente che non vedeva un confine netto tra il reale e il fantastico. Per fuggire, si rifugiò in un mondo immaginario, trovando conforto non nei santi, ma nei mostri.
I suoi impulsi creativi trovarono uno sfogo quando, intorno agli otto anni, iniziò a sperimentare con la cinepresa Super 8 di suo padre. I suoi primi film, con protagonisti i giocattoli de Il pianeta delle scimmie e altri oggetti di casa, erano già intrisi di una sensibilità cupa e comica. Un cortometraggio degno di nota presentava una “patata serial killer” con ambizioni di dominio del mondo, che uccideva la sua famiglia prima di essere schiacciata senza tante cerimonie da un’auto. Questo lavoro iniziale rivela una mente che già giocava con i cliché dell’horror, trovando uno strano e meraviglioso potere nel macabro. Il conflitto centrale dell’opera successiva di del Toro — lo scontro tra istituzioni rigide e crudeli e il “mostro” sensibile e incompreso — era una diretta esternalizzazione di questa infanzia. Non si limitò a rifiutare la fede di sua nonna; si appropriò della sua magniloquenza gotica, trasferendo il suo senso di stupore e terrore a una nuova mitologia personale di sua creazione.
L’apprendistato dell’artigiano: Da Necropia a Cronos
Il percorso di del Toro da giovane hobbista a regista professionista si è basato su una solida maestria pratica e manuale. Si iscrisse al corso di studi cinematografici dell’Università di Guadalajara, dove pubblicò anche il suo primo libro, una biografia di Alfred Hitchcock. Tuttavia, la sua formazione più cruciale non avvenne in un’aula, ma in un laboratorio. Ricercò e studiò effetti speciali e trucco sotto la guida del leggendario Dick Smith, l’artista dietro gli innovativi effetti de L’esorcista. Questo mentorato fu trasformativo. Per il decennio successivo, del Toro si dedicò al mestiere, lavorando come designer di trucco per effetti speciali e fondando infine la sua società a Guadalajara, Necropia. Durante questo periodo, affinò le sue abilità in programmi televisivi messicani come Hora Marcada, dove lavorò al fianco di futuri collaboratori come Alfonso Cuarón ed Emmanuel Lubezki, e co-fondò il Festival Internazionale del Cinema di Guadalajara.
Questa profonda comprensione tattile di come la magia del cinema viene fisicamente scolpita, modellata e portata in vita sarebbe diventata il fondamento del suo stile registico, instillando una preferenza per tutta la carriera per gli effetti pratici che conferiscono alle sue creazioni fantastiche un peso tangibile e viscerale. Questo intenso apprendistato culminò nel suo debutto cinematografico del 1993, Cronos. Il film, finanziato con un budget di circa 2 milioni di dollari che del Toro coprì in parte di tasca sua, fu la massima espressione del suo percorso come artigiano. Era un film finanziato e costruito sulla sua esperienza negli effetti pratici. Cronos racconta la storia di un anziano antiquario che scopre un dispositivo di 400 anni, simile a un insetto, che concede la vita eterna al costo di una sete di sangue vampiresca. Il film fu una compiuta dichiarazione d’intenti, presentando al mondo i motivi distintivi di del Toro: intricati meccanismi a orologeria, immagini di insetti, un mostro tragico e compassionevole e una profonda vena di simbolismo cattolico. Segnò anche la sua prima collaborazione con l’attore Ron Perlman, che interpretava un brutale americano a caccia del dispositivo.
Cronos fu un successo in Messico, trionfando ai Premi Ariel con nove vittorie, tra cui Miglior Film e Miglior Regista. In seguito vinse il prestigioso premio della Settimana Internazionale della Critica al Festival di Cannes, annunciando l’arrivo di una voce sorprendentemente originale nel cinema mondiale. Negli Stati Uniti, tuttavia, la sua distribuzione fu limitata e incassò appena 621.392 dollari. Il film fu un beniamino della critica ma una nota a margine dal punto di vista commerciale, un modello che avrebbe definito la fase successiva della sua carriera mentre si avventurava nel cuore del sistema di Hollywood.
La prova del fuoco: Il calvario di Mimic a Hollywood
In seguito al successo internazionale di Cronos, del Toro fece la sua prima incursione nel sistema degli studios americani con il film di fantascienza e horror del 1997 Mimic, prodotto dall’etichetta di genere di Miramax, Dimension Films. L’esperienza si sarebbe rivelata una traumatica prova del fuoco. Si scontrò costantemente con i produttori Bob e Harvey Weinstein, che a suo dire interferirono in ogni aspetto del progetto. Lo studio mise in discussione le sue decisioni su trama, casting e tono, chiedendo un film più convenzionale e “spaventoso” del suggestivo film di creature che del Toro aveva in mente. Il concetto originale, che prevedeva insetti bianchi e spettrali, fu cambiato in scarafaggi giganti mutanti, una mossa che del Toro temeva avrebbe trasformato il suo film nel “film degli scarafaggi giganti”.
Le battaglie creative divennero così intense che, secondo quanto riferito, Harvey Weinstein fece irruzione sul set di Toronto per istruire del Toro su come dirigere e in seguito cercò di farlo licenziare, un tentativo sventato solo dall’intervento dell’attrice protagonista, Mira Sorvino. Da allora del Toro ha definito la realizzazione di Mimic una delle peggiori esperienze della sua vita, un'”esperienza orribile, orribile, orribile” che ha paragonato sfavorevolmente al rapimento di suo padre. Alla fine disconobbe il montaggio cinematografico del film, anche se in seguito riuscì a pubblicare una versione del regista nel 2011 che ripristinava alcune delle sue intenzioni originali. Quel calvario lo allontanò quasi del tutto dal cinema americano.
Tuttavia, il trauma professionale di Mimic ebbe un impatto profondo e duraturo sul suo mestiere. In risposta al fatto che il suo lavoro veniva rimontato e controllato dallo studio, del Toro sviluppò consapevolmente uno stile registico specifico come forma di autoconservazione creativa. Iniziò a girare in un modo che sfidava un facile rimontaggio, impiegando movimenti di macchina fluidi, complessi e spesso lunghi che si intrecciano sul set. Questo stile di “camera fluttuante”, oggi celebrato come un marchio di fabbrica della sua arte, nacque come una tattica di sopravvivenza calcolata. Era un modo per rendere la macchina da presa un personaggio narrativo a pieno titolo, incorporando la logica narrativa così profondamente nel linguaggio visivo di un’inquadratura da non poter essere facilmente smantellata in sala di montaggio. Il dolore di Mimic forgiò gli stessi strumenti che avrebbe usato per costruire i suoi futuri capolavori.
Ritorno alle radici: Il gotico spagnolo de La spina del diavolo
Scosso dal suo calvario a Hollywood, del Toro intraprese un ritiro strategico e spiritualmente necessario. Tornò alle sue radici, fondando la sua società di produzione, The Tequila Gang, e imbarcandosi in una coproduzione in lingua spagnola tra Spagna e Messico. Il risultato fu La spina del diavolo (2001), una storia di fantasmi gotica profondamente personale che servì sia da rigenerazione creativa sia da modello tematico per la sua opera più celebrata.
Il film fu prodotto dal leggendario regista spagnolo Pedro Almodóvar e da suo fratello Agustín, attraverso la loro società El Deseo. Questa partnership si rivelò l’antidoto perfetto al veleno di Mimic. A del Toro fu concessa completa libertà creativa, un concetto così assoluto che quando chiese il montaggio finale, Pedro Almodóvar rimase sinceramente confuso, rispondendo: “Ma certo, la decisione è tua!”. Questo ambiente protetto permise a del Toro di ritrovare la sua voce e di guarire le ferite del suo film precedente. Riportò in vita una sceneggiatura che aveva scritto ancor prima di Cronos, una storia ambientata nel 1939, durante l’ultimo anno della Guerra Civile Spagnola. La trama segue un giovane ragazzo, Carlos, che viene mandato in un orfanotrofio infestato gestito da lealisti repubblicani. Lì, si confronta non solo con il fantasma di un bambino assassinato, ma anche con i mali molto umani dell’avidità e della violenza incarnati dal custode, Jacinto. Il film mescola magistralmente l’horror soprannaturale con la tragedia storica, stabilendo la Guerra Civile Spagnola come quello che del Toro avrebbe poi chiamato un “motore di fantasmi”, un trauma storico così profondo che i suoi spettri continuano a perseguitare il presente.
La spina del diavolo fu acclamato dalla critica come un capolavoro di atmosfera e metafora. Ancora più importante per del Toro, fu la conferma che la sua visione senza compromessi poteva dare vita a un cinema potente e risonante. Ha descritto il film come il “film fratello” de Il labirinto del fauno, una controparte più maschile dell’energia femminile della sua opera successiva. La realizzazione creativa e il successo di critica de La spina del diavolo furono la sessione di terapia artistica essenziale che non solo ripristinò la sua fiducia, ma pose anche le basi tematiche e storiche per il capolavoro che sarebbe venuto.
Alla conquista del mainstream: Blade II e la saga di Hellboy
Fortificato dal trionfo creativo de La spina del diavolo, del Toro tornò a Hollywood, ma questa volta alle sue condizioni. Prese le redini del sequel di supereroi e vampiri Blade II (2002), un progetto che gli permise di fondere la sua estetica gotica e mostruosa con l’azione adrenalinica da blockbuster. Stanco del cliché romantico degli “eroi vittoriani tormentati”, era determinato a rendere di nuovo spaventosi i vampiri. Il film fu un successo clamoroso, incassando 155 milioni di dollari e dimostrando che la sua sensibilità unica poteva prosperare all’interno di un franchise di grande consumo. Portò il suo amore caratteristico per gli effetti pratici, il design intricato delle creature — come gli terrificanti “Reapers” con le loro mascelle divise — e l’illuminazione suggestiva e d’atmosfera nel mondo dei film tratti dai fumetti, creando quello che molti fan considerano il punto più alto della trilogia.
Questo successo gli diede il peso necessario nel settore per perseguire un progetto che aveva accarezzato per anni: un adattamento del fumetto di Mike Mignola Hellboy. Il percorso per portare sullo schermo il demone dalla pelle rossa e dalla battuta pronta fu arduo, definito dalla lealtà incrollabile e dall’integrità artistica di del Toro. Per sette anni, combatté contro gli studi che esitavano sul progetto e, soprattutto, sulla sua scelta per il ruolo principale. Del Toro fu irremovibile sul fatto che solo un attore potesse incarnare l’anima del personaggio: il suo amico e frequente collaboratore, Ron Perlman. Si rifiutò di fare il film con chiunque altro, disposto a sacrificare l’intero progetto piuttosto che compromettere quello che sentiva essere il suo cuore.
La sua perseveranza fu ripagata. Hellboy uscì nel 2004, seguito dal sequel ancora più fantastico, Hellboy: The Golden Army, nel 2008. I film sono una vibrante vetrina delle passioni di del Toro. Sono pieni di effetti pratici e design di creature mozzafiato, molti dei quali scaturiti direttamente dai suoi taccuini personali. Affrontò questi film di franchise non come un regista su commissione, ma con la stessa passione autoriale che portava nel suo lavoro indipendente. Bilanciò l’azione esplosiva con un pathos genuino e un umorismo basato sui personaggi, umanizzando il suo eroe mostruoso e la sua famiglia acquisita di “fenomeni da baraccone”. In questo modo, del Toro confuse efficacemente il confine tra il cinema d’autore e i multiplex, dimostrando che per lui una storia su un mostro compassionevole era un’impresa degna, indipendentemente dal budget.
Il capolavoro: Dentro Il labirinto del fauno
Nel 2006, Guillermo del Toro realizzò il film che avrebbe definito la sua carriera e cementato il suo status come uno dei più importanti visionari cinematografici del mondo: Il labirinto del fauno (El laberinto del fauno). Una coproduzione internazionale tra Spagna e Messico, fu un progetto così personale che del Toro investì il proprio stipendio per garantirne il completamento. Il film è la sintesi definitiva di ogni tema, influenza e ossessione che avevano plasmato la sua vita e il suo lavoro fino a quel momento.
La storia, nata da vent’anni di idee, disegni e frammenti di trama raccolti nei suoi taccuini meticolosamente tenuti, è ambientata nel 1944, cinque anni dopo la Guerra Civile Spagnola. Segue una giovane ragazza di nome Ofelia che viaggia con la madre incinta verso un avamposto militare rurale comandato dal suo sadico nuovo patrigno, il Capitano falangista Vidal. Fuggendo dalla brutale realtà della sua nuova vita, Ofelia scopre un antico labirinto e un misterioso fauno, che le dice che è una principessa perduta del sottomondo. Per reclamare il suo regno, deve completare tre pericolosi compiti.
Il labirinto del fauno è una miscela magistrale e straziante di una fiaba cupa in stile fratelli Grimm con la brutalità inflessibile della Spagna franchista del dopoguerra. Il mondo fantastico non è una semplice fuga dalla realtà, ma piuttosto una lente metaforica attraverso cui Ofelia elabora e affronta i suoi orrori. I temi della scelta e della disobbedienza sono centrali; Ofelia viene costantemente messa alla prova, costretta a scegliere tra l’obbedienza cieca a figure autoritarie come Vidal e il Fauno, and e la propria bussola morale innata. La creazione più terrificante del film, l’Uomo Pallido, un divoratore di bambini, è un’allegoria diretta dei mali istituzionali del fascismo e della Chiesa Cattolica complice.
Il film fu presentato in anteprima al Festival di Cannes del 2006, dove fu accolto da una standing ovation di 22 minuti, una delle più lunghe nella storia del festival. Divenne un fenomeno globale, incassando oltre 83 milioni di dollari con un modesto budget di 19 milioni e ottenendo unanimi consensi dalla critica. Ricevette sei nomination ai Premi Oscar, tra cui Miglior Sceneggiatura Originale per del Toro, e vinse tre Oscar per Fotografia, Scenografia e Trucco. Il film fu la distillazione perfetta della sua intera identità artistica, l’opera verso cui tutta la sua carriera era stata costruita, e gli garantì un immenso capitale creativo for per tutte le sue future imprese.
L’autore come produttore e collaboratore
Dopo il monumentale successo de Il labirinto del fauno, l’influenza di del Toro si espanse ben oltre il suo lavoro di regista. Consolidò il suo ruolo di forza generatrice centrale nella narrazione fantasy moderna, usando la sua ritrovata influenza per sostenere altri registi ed espandere il suo universo creativo su più piattaforme. Il suo lavoro come produttore non è un’attività secondaria, ma un’estensione diretta del suo impulso di costruttore di mondi. Incapace di dirigere personalmente ogni storia che cattura la sua immaginazione — come il suo famoso e agognato progetto mai realizzato, un adattamento de Le montagne della follia di H.P. Lovecraft — usa la sua influenza per dare vita a mondi tematicamente affini.
Ha agito come produttore e mentore in acclamati film horror in lingua spagnola come The Orphanage (2007) di J.A. Bayona e La madre (2013) di Andy Muschietti, coltivando nuovi talenti nel genere che ama. È diventato anche una forza creativa chiave nell’animazione, servendo come produttore esecutivo in film della DreamWorks Animation come Il gatto con gli stivali (2011), Le 5 leggende (2012) e i sequel di Kung Fu Panda. La sua portata si è estesa anche a franchise di successo e alla televisione. Dopo essere stato associato alla regia dell’adattamento cinematografico de Lo Hobbit, alla fine si ritirò dalla sedia del regista ma rimase co-sceneggiatore accreditato in tutti e tre i film della trilogia di Peter Jackson, plasmando la narrazione della Terra di Mezzo. Si è avventurato in televisione come co-creatore e produttore esecutivo della serie FX The Strain (2014-2017), basata sulla trilogia di romanzi sui vampiri che ha scritto insieme a Chuck Hogan. Per Netflix, ha creato l’ampio e amato franchise animato I racconti di Arcadia, che comprende le serie Trollhunters, 3 in mezzo a noi e I Maghi. Attraverso questi diversi progetti, del Toro cura efficacemente un universo condiviso più grande di dark fantasy, usando il suo nome e le sue risorse per costruire il suo “gabinetto delle curiosità” su una scala molto più grande di quanto potrebbe raggiungere da solo.
Una storia d’amore non convenzionale: La forma di un Oscar
Nel 2017, Guillermo del Toro ha diretto il film che gli avrebbe portato i massimi riconoscimenti del settore: La forma dell’acqua – The Shape of Water. La genesi del film risiedeva in un ricordo d’infanzia: guardare Il mostro della laguna nera e desiderare che il mostro e la protagonista femminile potessero riuscire nella loro storia d’amore. Decenni dopo, ha dato vita a quel desiderio in una favola dell’era della Guerra Fredda che è diventata la sua opera più celebrata.
Ambientata a Baltimora nel 1962, la storia è incentrata su Elisa Esposito, un’addetta alle pulizie muta in un laboratorio governativo segreto. La sua vita di silenzioso isolamento viene trasformata quando scopre il bene più sensibile del laboratorio: una creatura umanoide anfibia catturata nel Rio delle Amazzoni. Mentre forma un legame silenzioso con la creatura, scopre un complotto di un sadico agente governativo per vivisezionarla. Il film è una bellissima e malinconica ode agli emarginati, con la famiglia acquisita di Elisa — il suo vicino di casa gay non dichiarato e la sua collega afroamericana — che rappresenta le voci marginalizzate dell’epoca. Realizzato con un budget relativamente modesto di 19,5 milioni di dollari, La forma dell’acqua è una lezione magistrale di atmosfera ed emozione, che usa la sua ambientazione del 1962 come “una favola per tempi difficili” per commentare le ansie sociali e politiche dei giorni nostri.
Il film è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Leone d’Oro, per poi diventare un gigante della critica e della stagione dei premi. La sua notte trionfale è arrivata alla 90ª edizione dei Premi Oscar. Il film, che aveva ottenuto ben tredici nomination, ha vinto quattro Oscar, tra cui Miglior Scenografia, Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Regista per del Toro e l’ambito premio per il Miglior Film. È stato un momento storico. Per decenni, i film di genere erano stati in gran parte relegati alle categorie tecniche dai principali organi di premiazione. Con questa vittoria, l’Academy ha abbracciato pienamente l’argomento sostenuto da del Toro per tutta la sua carriera: che una storia su un mostro, e una storia d’amore tra una donna e un “uomo pesce”, potesse essere tanto profonda, artistica e degna del più alto onore del settore quanto qualsiasi dramma tradizionale. La “materia vile” che tanto amava era stata alchemicamente trasformata in oro cinematografico agli occhi dell’establishment.
Una visione in evoluzione: Noir, animazione e il futuro
Negli anni successivi al suo trionfo agli Oscar, del Toro ha continuato a evolversi come artista, esplorando nuovi generi e allo stesso tempo raddoppiando le sue passioni più antiche. Nel 2021 ha distribuito La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, un’opera significativamente diversa in quanto suo primo lungometraggio senza elementi soprannaturali. Sontuoso e cupo adattamento del romanzo di William Lindsay Gresham del 1946, il film è una pura e oscura esplorazione dell’ambizione e della depravazione umana, che dimostra la sua padronanza del noir classico. Con la sua straordinaria scenografia e un’interpretazione magistrale di Bradley Cooper, il film ha ottenuto quattro nomination ai Premi Oscar, tra cui Miglior Film, dimostrando che la sua abilità artistica si estendeva oltre il regno del fantastico.
Ha poi proseguito con un progetto che era in gestazione da oltre un decennio: Pinocchio di Guillermo del Toro (2022). Tornando al suo primo amore, l’animazione stop-motion, ha reinventato la storia classica non come un racconto per bambini, ma come una favola cupa e profonda sulla vita, la morte e la disobbedienza, ambientata sullo sfondo dell’Italia fascista di Mussolini. Il film è stato una meraviglia tecnica ed emotiva, celebrato per la sua bellezza artigianale e i suoi temi maturi e antifascisti. Ha dominato la stagione dei premi, culminando in un’altra vittoria agli Oscar per del Toro, questa volta per il Miglior Film d’Animazione.
Questa vittoria ha consolidato un nuovo percorso per il regista. Ha dichiarato che, dopo un altro paio di film live-action, intende dedicare il resto della sua carriera principalmente all’animazione, un mezzo che considera la “forma d’arte più pura” e quella che offre il massimo controllo creativo. Per un regista ossessionato dalla meticolosa costruzione di mondi — un desiderio nato dai suoi film d’infanzia in Super 8 e consolidato dal trauma delle interferenze degli studi — lo stop-motion rappresenta l’ultima frontiera. È l’unico mezzo in cui la mano del regista è letteralmente in ogni singolo fotogramma, un’espressione diretta e senza compromessi della sua volontà. Questa svolta chiude il cerchio del suo viaggio, dal ragazzo che animava i suoi giocattoli a Guadalajara al maestro che anima i suoi burattini su un palcoscenico globale.
Una passione di una vita che risorge: Frankenstein
Nel 2025, del Toro è pronto a distribuire Frankenstein, un progetto che rappresenta il culmine di un’ossessione artistica durata una vita. Per del Toro, la storia non è solo un classico del genere; è una religione personale. Ha raccontato di aver visto il mostro di Boris Karloff da bambino e di aver capito per la prima volta “quale fosse l’aspetto di un santo o di un messia”. Questo legame profondamente personale ha alimentato per decenni il suo desiderio di adattare il romanzo di Mary Shelley, aspettando le condizioni giuste per creare una versione che potesse ricostruire l’intero mondo della storia sulla scala appropriata.
La sua visione per il film non è quella di un horror convenzionale, ma piuttosto di una “storia incredibilmente emotiva”. Il suo obiettivo è ricatturare la sensazione di leggere il romanzo per la prima volta, prima che i suoi personaggi diventassero caricature culturali. La narrazione si concentrerà sulla complessa relazione tra creatore e creazione, esplorando temi di paternità e figliolanza profondamente radicati nella vita stessa di del Toro. Il film vede come protagonisti Oscar Isaac nel ruolo del brillante ed egocentrico scienziato Victor Frankenstein, e Jacob Elordi che assume il ruolo della sua tragica creazione. Il cast include anche Mia Goth, Christoph Waltz e Charles Dance. Il film è previsto per un’uscita limitata nelle sale il 17 ottobre 2025, prima di essere distribuito in streaming a livello globale su Netflix il 7 novembre 2025. Del Toro ha descritto il film come la fine di un’era per lui, una grande sintesi delle preoccupazioni estetiche, ritmiche ed empatiche che hanno definito il suo lavoro da Cronos fino ad oggi.
Il santo patrono dell’imperfezione
La carriera di Guillermo del Toro è una testimonianza del potere di una visione singolare e profondamente personale. Il suo viaggio da ragazzo ossessionato dai mostri a Guadalajara a celebre maestro di favole moderne è stato definito da un impegno incrollabile verso le sue convinzioni fondamentali. Ha costantemente difeso gli emarginati, gli “altri” e gli imperfetti, trovando in loro una bellezza piena di sentimento che riflette la nostra stessa umanità imperfetta. Il suo fermo anti-autoritarismo, che sia diretto contro la macchina del fascismo o il dogma della chiesa, scorre come una potente corrente sotterranea in tutta la sua opera. È un autore nel senso più puro del termine, le cui preoccupazioni tematiche e il cui linguaggio visivo distintivo sono immediatamente riconoscibili. I suoi film sono cupi ma speranzosi, grotteschi ma poetici, e operano sulla profonda comprensione che le fiabe non sono una fuga dalla realtà, ma uno strumento vitale per navigare nei suoi angoli più bui.
Guillermo del Toro non si limita a creare mostri; li capisce, li ama e li vede come i santi patroni di un mondo che ha un disperato bisogno di abbracciare le proprie imperfezioni. In questo modo, ci porge uno specchio meravigliosamente strano e profondamente empatico, che riflette il mostruoso e il magico che sono dentro tutti noi.