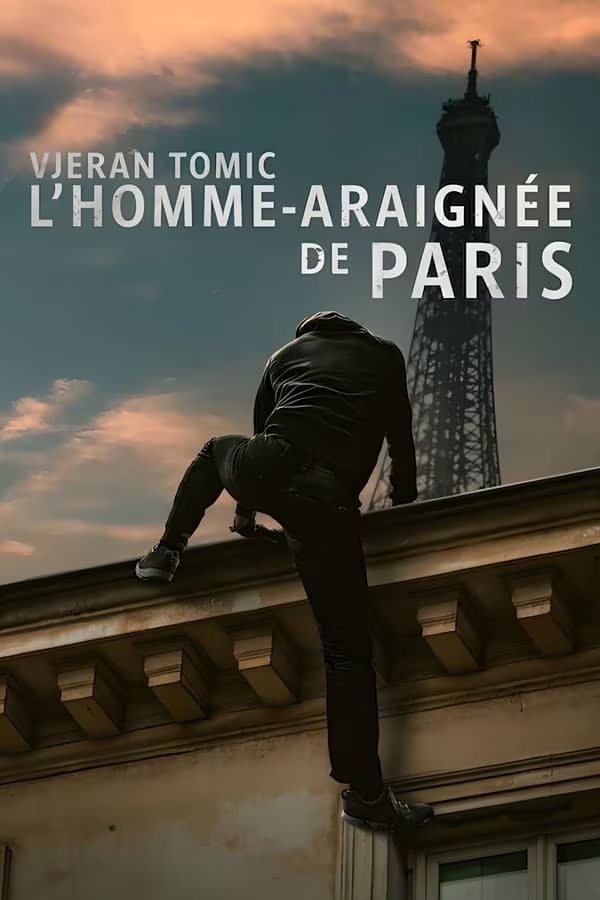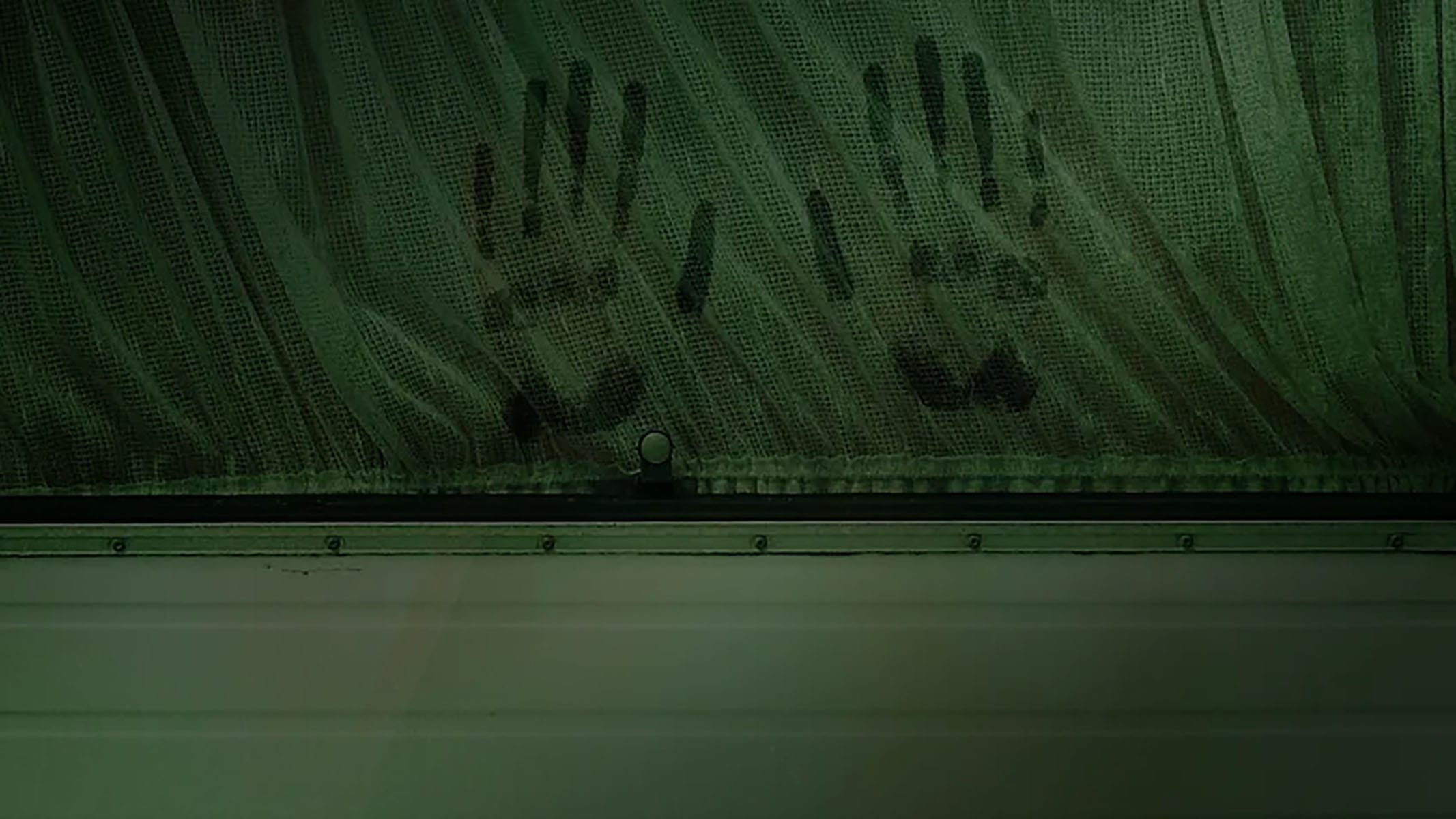Per più di due decenni, è stato il monolito stoico e serioso al centro della televisione americana, un uomo la cui immagine sullo schermo era così notoriamente rigida che i comici hanno costruito intere carriere imitando la sua postura impettita e le sue goffe presentazioni. Eppure, ogni domenica sera, dal 1948 al 1971, decine di milioni di americani si riunivano per il suo “really big shew” (show davvero grande), rendendo l’Ed Sullivan Show un’istituzione nazionale e il suo conduttore il più potente arbitro culturale del paese. Un nuovo documentario del regista Sacha Jenkins, Sunday Best: la storia di Ed Sullivan, rivisita questa imponente figura della storia dei media, proponendo una rilettura radicale della sua eredità. Il film, che include testimonianze di un’ampia gamma di ammiratori come Ringo Starr, Bruce Springsteen e Ice-T, sostiene che dietro la “grande faccia di pietra” si nascondesse un rivoluzionario silenzioso, un uomo che usò deliberatamente e costantemente la sua impareggiabile piattaforma per promuovere la causa dell’integrazione razziale, inviando un messaggio sovversivo di uguaglianza nei salotti di un’America profondamente segregata.
Il documentario si propone di raccontare la “storia mai raccontata” promessa nel titolo, andando oltre i noti aneddoti sul lancio di Elvis e dei Beatles per svelare una narrazione più profonda e politicamente carica, nascosta in piena vista. Per farlo, impiega un espediente narrativo unico e avvincente: utilizzando la tecnologia vocale basata sull’intelligenza artificiale di Respeecher, il film resuscita la voce stessa di Sullivan per narrare la sua storia, attingendo al vasto archivio delle sue rubriche giornalistiche, articoli e lettere personali. Questa tecnica crea un’intimità immediata e sorprendente, dando l’impressione che sia Sullivan stesso a fare chiarezza, postumo. È una scelta strategica che inquadra il film non solo come un resoconto storico, ma come un atto di rivendicazione, sfidando gli spettatori a riconsiderare un uomo che pensavano di conoscere e l’epoca che ha contribuito a definire. Il film postula che il contributo più significativo di Sullivan non sia stato solo scoprire nuove stelle, ma cambiare per sempre il suono — e il volto — dell’America.

L’uomo dietro il monolito
Per comprendere la convinzione dietro le decisioni di Sullivan sullo schermo, Sunday Best: la storia di Ed Sullivan costruisce un dettagliato ritratto biografico che stabilisce una filosofia personale profondamente radicata di equità e inclusione. Il film ripercorre le sue origini fino alla nascita ad Harlem nel 1901, un’epoca in cui il quartiere era un vivace miscuglio di famiglie irlandesi ed ebraiche. Sottolinea i valori instillatigli dai genitori, che gli insegnarono a rispettare le persone indipendentemente dalla loro provenienza, e ricorda la precoce tragedia della morte del fratello gemello a pochi mesi dalla nascita. Questa base di egualitarismo e perdita personale viene presentata come un elemento cruciale del suo carattere.
Il documentario segue le sue esperienze formative, che lo collocarono in ambienti diversi e integrati molto prima che fosse comune. Fu un atleta di talento che giocò in una lega di baseball integrata al liceo, un’esperienza che lo espose a coetanei neri come pari sul campo sportivo. La sua vita professionale iniziò come cronista sportivo prima di una svolta fondamentale che lo portò a diventare editorialista di Broadway per il The New York Daily News, dove la sua rubrica, “Little Ole New York”, lo immerse nel poliedrico mondo del teatro newyorkese. Fu qui, sostiene il film, che la sua visione del mondo si consolidò. Questa storia personale fu ulteriormente plasmata dal suo matrimonio con Sylvia Weinstein, una donna ebrea. La loro relazione incontrò una forte opposizione da entrambe le famiglie, offrendo a Sullivan una comprensione diretta e personale del pregiudizio e del bigottismo. Il film traccia una linea netta da questi eventi della sua vita alle sue azioni come conduttore televisivo. Suggerisce che le sue scelte di programmazione non furono frutto del caso o anche solo di un buon fiuto per gli affari, ma l’espressione deliberata di una convinzione di una vita. Le sue origini irlandesi e l’esperienza di sua moglie con l’antisemitismo gli fornirono una lente potente ed empatica attraverso cui guardare alle lotte degli artisti neri in una società razzista. Il documentario costruisce un caso secondo cui il suo pacato attivismo sullo schermo fu preceduto da decenni di convinzioni personali, indicando la sua produzione di una rivista di Broadway interamente nera, Harlem Cavalcade, negli anni ’40 e la sua stretta amicizia con artisti come il ballerino Bill “Bojangles” Robinson, il cui funerale Sullivan organizzò e finanziò personalmente, assicurando che la stella, morta in povertà, ricevesse un addio grandioso degno del suo talento.
Il potere della piattaforma
Prima di addentrarsi nella sua tesi centrale, il documentario stabilisce meticolosamente l’immensa portata e il peso culturale dell’Ed Sullivan Show, che iniziò la sua vita come Toast of the Town. Per 23 anni, il programma fu un rito della domenica sera, un’esperienza culturale condivisa che univa le famiglie americane in un’era precedente alla TV via cavo, allo streaming o ai social media. Il film sottolinea le dimensioni sbalorditive del suo pubblico, che raggiungeva regolarmente tra i 35 e i 50 milioni di spettatori ogni settimana, garantendo a Sullivan un livello di influenza quasi inimmaginabile oggi. Questa enorme portata rese il suo palco la più importante piattaforma dell’intrattenimento americano. Un’apparizione era ampiamente considerata una garanzia di successo, capace di trasformare un quasi sconosciuto in un nome familiare da un giorno all’altro. Il film illustra questo status di “creatore di stelle” con un potente montaggio dei diversi talenti che ottennero la loro prima grande visibilità nazionale nel suo show, da duo comici come Dean Martin e Jerry Lewis a future leggende come Dick Van Dyke e Jack Benny.
Il documentario analizza la formula ingannevolmente semplice di Sullivan per il successo: “Apri in grande, abbi un buon numero comico, inserisci qualcosa per i bambini e mantienilo pulito”. Questo impegno per la varietà creò uno spettacolo con un appeal ampio e trasversale. In una qualsiasi domenica, gli spettatori potevano vedere i più acclamati cantanti d’opera e corpi di ballo del mondo condividere il palco con giocolieri di piatti, acrobati, burattinai come Topo Gigio, ventriloqui come Señor Wences e comici del Borscht Belt. Questa miscela di “cultura alta, cultura bassa e tutto ciò che sta in mezzo” assicurava che ci fosse qualcosa per ogni membro della famiglia, cementando il dominio dello show per più di due decenni. Quantificando questo potere, il film stabilisce l’alta posta in gioco della programmazione di Sullivan. Quando un conduttore ha l’attenzione indivisa di quasi metà del paese, ogni scelta diventa significativa. In questo contesto, la decisione di presentare un artista nero non era semplicemente una prenotazione di intrattenimento; era una dichiarazione politica con profonde implicazioni sociali. Il palco dell’Ed Sullivan Theater diventa una metafora dell’America stessa, e Sullivan, come arbitro supremo, controllava chi veniva accolto nei salotti della nazione. L’argomento centrale del film si basa sulla premessa che egli usò consapevolmente questo potere non per rafforzare lo status quo segregato, ma per smantellarlo metodicamente.
Il campo di battaglia televisivo per i diritti civili
Il cuore di Sunday Best: la storia di Ed Sullivan è la sua avvincente e meticolosamente documentata tesi secondo cui Ed Sullivan fu un pioniere dei diritti civili. Il film giustappone le esibizioni eleganti, dignitose e potenti di artisti neri sul suo palco — tra cui leggende come Ray Charles, James Brown, Nina Simone e Diana Ross and The Supremes — con filmati d’archivio crudi e senza filtri del razzismo violento dell’epoca, incluse immagini del Ku Klux Klan e interviste a segregazionisti impenitenti. Questo contrasto evidenzia la natura rivoluzionaria di ciò che Sullivan stava facendo. In un’epoca in cui gli unici volti neri in televisione erano spesso caricature razziste come quelle di Amos ‘n’ Andy, Sullivan presentava gli intrattenitori neri come artisti posati, colti e di supremo talento. Il documentario fornisce numerosi esempi di Sullivan che si oppose fermamente alle immense pressioni degli inserzionisti e delle affiliate televisive del sud che si opponevano alla sua scelta di artisti neri. Quando gli sponsor, inclusi i potenti concessionari Lincoln della Ford Motor Company, minacciarono di ritirare il loro sostegno, Sullivan non si tirò indietro. Ignorò le critiche secondo cui presentava troppi artisti neri o che non avrebbero dovuto essere accompagnati da musicisti bianchi sul suo palco.
Il film si concentra su gesti piccoli ma simbolicamente enormi che erano radicali per l’epoca. In televisione nazionale, Sullivan strinse pubblicamente la mano a Nat King Cole e baciò sulla guancia la cantante Pearl Bailey — atti di semplice calore umano e rispetto che sfidavano i tabù razzisti dell’epoca e scatenarono l’indignazione degli spettatori bigotti. Questi momenti, sostiene il film, erano calcolati per umanizzare gli artisti neri agli occhi di un pubblico bianco condizionato a vederli come inferiori. Questa costante presentazione dell’eccellenza nera ebbe un impatto profondo. Il documentario traccia una linea diretta tra il palco di Sullivan e l’esplosione mainstream della Motown. Fornendo una piattaforma nazionale ricorrente ad artisti come The Supremes, The Temptations, Stevie Wonder e The Jackson 5, Sullivan fu determinante nel rendere la loro musica “il suono della giovane America”. Il film presenta potenti interviste con il fondatore della Motown Berry Gordy e il cantante Smokey Robinson, che testimoniano in prima persona il ruolo essenziale di Sullivan nel loro successo. Il documentario contrappone il sostegno visivo di Sullivan all’ammissione dello stesso Gordy di aver inizialmente evitato di mettere volti neri sulle copertine degli album Motown per paura di alienare gli acquirenti di dischi bianchi, sottolineando il potere rivoluzionario della presentazione televisiva di Sullivan. Il suo palco divenne un braccio performativo del Movimento per i Diritti Civili stesso, ospitando la cantante gospel preferita di Martin Luther King Jr., Mahalia Jackson, e in seguito fornendo una piattaforma a Coretta Scott King per parlare alla nazione dopo l’assassinio di suo marito. Il punto più risonante del film è che l’attivismo di Sullivan era sovversivo. Non faceva grandi discorsi politici; semplicemente normalizzava il genio nero, settimana dopo settimana. Questa integrazione implacabile e concreta, trasmessa direttamente nello spazio intimo della casa americana, fu un potente strumento per cambiare i cuori e le menti.
Dai fianchi di Elvis all’invasione britannica
Per contestualizzare la grandezza del suo impegno per i diritti civili, il documentario rivisita i due più famosi terremoti culturali che scoppiarono sul palco di Sullivan. Il primo fu Elvis Presley. Il film racconta il rifiuto pubblico iniziale di Sullivan di ingaggiare il controverso cantante, i cui ancheggiamenti erano considerati troppo “volgari” per un pubblico familiare. Tuttavia, dopo aver visto gli enormi ascolti che Elvis ottenne su programmi rivali, Sullivan cedette, firmandolo per la cifra senza precedenti di 50.000 dollari per tre apparizioni. La prima apparizione, il 9 settembre 1956, attirò oltre 60 milioni di spettatori, rappresentando uno sbalorditivo 82,6% dell’intero pubblico televisivo. Eseguendo successi come “Don’t Be Cruel”, “Love Me Tender” e “Hound Dog”, Presley creò una sensazione nazionale. Il film copre la leggendaria terza esibizione, in cui i censori della rete ordinarono notoriamente che Elvis fosse filmato solo dalla vita in su. Eppure, alla fine dello spettacolo, Sullivan mise un braccio intorno al cantante e garantì personalmente per lui, dicendo all’America: “Questo è un ragazzo davvero perbene e bravo”. Questo sigillo di approvazione dal conduttore più fidato della televisione fu determinante per rendere il controverso rocker accettabile per l’America mainstream.
Il secondo evento sismico fu il debutto americano dei Beatles. Il documentario descrive come la rete internazionale di talent scout di Sullivan lo portò alla band mesi prima che fossero conosciuti negli Stati Uniti. La loro prima esibizione, il 9 febbraio 1964, divenne l’evento televisivo più visto della storia fino a quel momento, con 73 milioni di persone sintonizzate. Il film presenta questo momento come più di un semplice debutto musicale; fu il lancio ufficiale dell’invasione britannica e un punto di riferimento culturale per un’intera generazione, fornendo una scossa di energia giovanile tanto necessaria a una nazione ancora in lutto dopo l’assassinio del presidente Kennedy. Mentre la band si lanciava in “All My Loving”, “Till There Was You” e “She Loves You”, lo show contribuì a plasmare la loro identità per il nuovo pubblico americano, con dettagli come le didascalie sullo schermo che identificavano ogni membro, inclusa la giocosa scritta “SORRY GIRLS, HE’S MARRIED” (Spiacenti ragazze, è sposato) per John Lennon. Mettendo queste storie iconiche e ben note accanto alla promozione sostenuta e decennale di artisti neri, il film avanza un potente argomento implicito. Suggerisce che, mentre tutti ricordano dove si trovavano quando suonarono i Beatles, la rivoluzione più silenziosa e persistente che Sullivan condusse a favore dell’uguaglianza razziale fu una parte altrettanto, se non più, consequenziale della sua eredità.
Un’eredità complicata
Sunday Best: la storia di Ed Sullivan evita la semplice agiografia, presentando un ritratto sfumato di un uomo complesso e spesso contraddittorio. Sebbene progressista in materia di razza, Sullivan era anche un produttore autoritario che gestiva il suo show con “pugno di ferro” ed era noto per le sue leggendarie faide. Il documentario non nasconde i suoi famosi scontri con artisti che sfidavano il suo controllo o la sua sensibilità conservatrice. È famoso per aver bandito il pioniere del rock and roll Bo Diddley dopo che il chitarrista, a cui era stato chiesto di eseguire “Sixteen Tons” di Tennessee Ernie Ford, suonò invece la sua hit, “Bo Diddley”. I Doors furono banditi dopo che Jim Morrison, nonostante avesse concordato in precedenza di modificare un verso di “Light My Fire”, cantò la frase originale “girl, we couldn’t get much higher” (ragazza, non potremmo andare più in alto) durante la trasmissione in diretta. I Rolling Stones furono costretti a cantare “let’s spend some time together” (passiamo un po’ di tempo insieme) invece di “let’s spend the night together” (passiamo la notte insieme), con Mick Jagger che alzava gli occhi al cielo verso la telecamera in segno di protesta. E Bob Dylan lasciò il set prima della sua esibizione quando un dirigente della CBS gli disse che non poteva cantare la sua satira politicamente carica, “Talkin’ John Birch Paranoid Blues”. Persino Buddy Holly si attirò le ire di Sullivan quando insistette per suonare “Oh, Boy!” contro il volere del conduttore, il che portò Sullivan a pronunciare male il suo nome in onda e a far abbassare il volume del suo amplificatore di chitarra.
Inoltre, il film riconosce che il progressismo di Sullivan aveva i suoi limiti. Lo stesso uomo che si oppose agli sponsor razzisti capitolò anche alle pressioni della lista nera anticomunista di Red Channels, denunciando artisti con presunte simpatie di sinistra. Ciò è in netto contrasto con la sua ferma lealtà a Harry Belafonte, che continuò a sostenere anche dopo che Belafonte fu inserito nella lista nera. Queste contraddizioni rivelano un uomo che era un progressista che lavorava all’interno di un quadro profondamente conservatore. La sua lotta per l’uguaglianza razziale e la sua intolleranza per la controcultura rock bianca potrebbero derivare dallo stesso luogo: una credenza in una particolare visione di un’America ordinata e patriottica. Vedeva l’integrazione razziale come un imperativo morale necessario per realizzare la promessa della nazione, mentre considerava la ribellione, i riferimenti alla droga e l’anticonformismo di una generazione successiva di artisti come una minaccia a quello stesso ideale. Era un uomo che infranse coraggiosamente una delle regole sociali più importanti della sua epoca, applicandone ferocemente molte altre.
Una valutazione finale
Alla fine, Sunday Best: la storia di Ed Sullivan di Sacha Jenkins riesce nel suo ambizioso obiettivo. Riformula in modo convincente un monolito culturale, chiedendo a una nuova generazione di spettatori di guardare oltre la postura goffa e la dizione notoriamente rigida per vedere il cuore di un rivoluzionario silenzioso. Il più grande contributo del documentario è la sua potente illustrazione della capacità della televisione di normalizzare il cambiamento sociale. Sostiene che l’eredità più duratura di Sullivan non risiede solo nelle innumerevoli stelle che ha presentato al mondo, ma nelle profonde barriere sociali che ha contribuito a infrangere. Per 23 anni, ha usato il suo “really big shew” per presentare una visione integrata e armoniosa dell’America a una nazione che era tutto il contrario. In tal modo, ha sostenuto un’idea semplice ma radicale: che il talento, la dignità e il genio non conoscono colore.
Il documentario di 90 minuti è stato presentato in anteprima su Netflix nell’anno 2025.