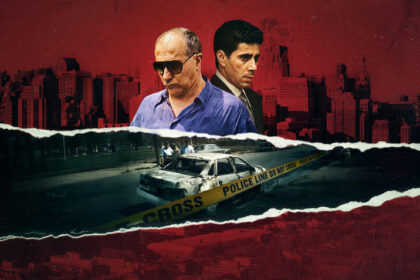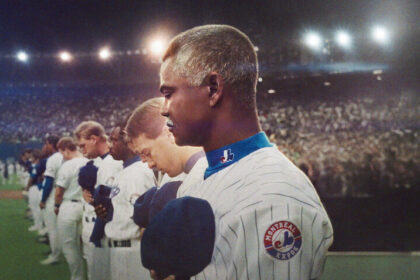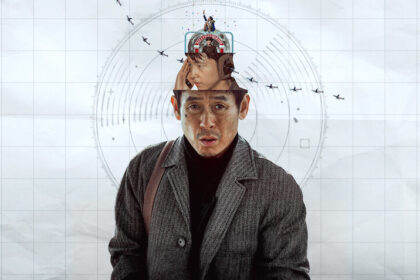Nella sua trasposizione cinematografica del bruciante romanzo di Willy Vlautin del 2021, il regista Benjamin Caron plasma La notte arriva sempre come un’opera di profonda urgenza sociale e psicologica. Il film si sviluppa come un’odissea propulsiva di 108 minuti che sposa la meccanica implacabile del thriller con i crudi dogmi del realismo sociale. È una critica incisiva a una società ossessionata dalla ricchezza e un’ispezione straziante delle brutali conseguenze della gentrificazione. Ambientato nel corso di una singola, pericolosa notte a Portland, Oregon, Caron ha modellato un thriller con un’anima per un’era di sviluppo urbano senz’anima, una storia che trova la sua tensione non in una suspense artefatta, ma nella fin troppo reale disperazione della sopravvivenza economica.
Al centro di questa discesa notturna c’è Lynette, una donna la cui precarietà è resa con un impegno feroce da Vanessa Kirby, che funge anche da produttrice. Kirby incarna una figura spinta al limite assoluto, una donna gravata da un cattivo credito e che si destreggia tra più lavori — alcuni illeciti — in una tenace ricerca di stabilità. Il suo unico obiettivo è acquistare la fatiscente casa in affitto che condivide con la madre amareggiata, Doreen (Jennifer Jason Leigh), e il fratello maggiore con disabilità dello sviluppo, Kenny. In un mercato immobiliare che ha visto i valori quadruplicare, l’offerta scontata del padrone di casa rappresenta un’ultima, fugace possibilità di sicurezza che la sua famiglia non ha mai conosciuto. L’incidente scatenante del film è un momento di tradimento casuale e devastante: appena una settimana prima della firma dei documenti del prestito, sua madre si tira indietro sulla promessa di aiutarla, mandando in frantumi il piano meticolosamente costruito da Lynette. Questo atto catalizza una ricerca frenetica per raccogliere 25.000 dollari prima del mattino, una missione che la costringe a tornare nei bassifondi criminali della città per affrontare una sfilza di uomini avidi e faccendieri ambiziosi. Il progetto segna una significativa reunion per Caron e Kirby, che hanno collaborato in precedenza in The Crown, scambiando qui la gabbia dorata della regalità britannica con i margini precari della classe operaia americana.
Portland come un campo di battaglia del noir moderno
Il peso tematico del film è ancorato alla sua magistrale trasposizione delle convenzioni del noir classico nel paesaggio ipermoderno di Portland. L’investigatore privato hard-boiled viene soppiantato da una donna della classe operaia la cui indagine non riguarda un crimine, ma la possibilità della propria sopravvivenza all’interno di un sistema di esclusione economica. In questa iterazione contemporanea del noir, la città stessa diventa l’antagonista principale. Portland non è un semplice sfondo, ma una forza attiva e ostile, una manifestazione fisica delle pressioni sistemiche che schiacciano la sua protagonista. La narrazione è acutamente consapevole delle dinamiche socio-economiche in gioco, dando vita cinematografica al sentimento del romanzo di Vlautin secondo cui i nuovi e scintillanti edifici della città servono solo come un costante e imponente promemoria della propria insignificanza. Questa visione è realizzata attraverso una potente collaborazione tra Caron e il direttore della fotografia Damián García, una partnership forgiata sulla serie visivamente sofisticata Andor. L’esperienza di García in progetti crudi come Narcos: Messico fornisce la precisa grammatica visiva necessaria per catturare una città di forti contrasti: le facciate impersonali delle nuove costruzioni contrapposte all’intimità logora della casa che Lynette lotta per mantenere. Caron e García applicano efficacemente il formato di alta produzione e incentrato sui personaggi della televisione di prestigio a una storia di fallimento sistemico, elevando una critica al capitalismo contemporaneo con la stessa gravitas narrativa di una ribellione galattica.
L’energia ferina di un’eroina imperfetta
La tempesta della narrazione è canalizzata attraverso l’elettrizzante performance centrale di Vanessa Kirby, un ritratto della disperazione che appare al contempo ferino e meticolosamente controllato. È un personaggio forgiato nel crogiolo del fallimento sistemico, un’antieroina imperfetta le cui azioni discutibili nascono da uno stato di eccezione. Kirby ha parlato del profondo significato che ha trovato nell’interpretare qualcuno al limite assoluto, una posizione che infonde ogni azione successiva di una pericolosa imprevedibilità. Il risultato è una performance che agisce senza rete di sicurezza, oscillando tra profonda fragilità e sorprendente ferocia. Questo ritratto crudo è amplificato da una serie di scelte tecniche deliberate, la più significativa delle quali è la decisione di Caron di girare l’intero film dal punto di vista soggettivo di Lynette. Non si tratta di un vezzo stilistico, ma di una strategia narrativa fondamentale che annulla la distanza tra spettatore e personaggio, forzando un allineamento con le sue decisioni spesso moralmente ambigue. La scelta di girare in sequenza — un metodo logisticamente complesso — serve ulteriormente la performance, consentendo una costruzione autentica, momento per momento, del crollo psicologico di Lynette. La produzione sembra architettata per catturare questa energia selvaggia, dimostrando come l’investimento creativo di una star come produttrice possa plasmare direttamente la grammatica tecnica ed emotiva di un film.
L’architettura tecnica di una notte frenetica
L’architettura dell’atmosfera opprimente del film è meticolosamente ingegnerizzata attraverso la sua sceneggiatura e il suo paesaggio sonoro. La sceneggiatura, firmata da Sarah Conradt, il cui background include thriller come Mothers’ Instinct, traduce con successo l’energia frenetica del romanzo in una struttura cinematografica serrata. Comprimendo la linea temporale in 108 minuti implacabili, la sceneggiatura mantiene un senso di costante slancio in avanti. All’interno di questa cornice, lunghe conversazioni cariche di emozione funzionano come strumenti di scavo psicologico, portando alla luce anni di storia complessa e traumi condivisi. Il mondo sonoro del film, creato dal compositore Adam Janota Bzowski, rappresenta una scelta artistica altrettanto determinante. Noto per il suo lavoro nominato ai BAFTA per l’horror psicologico Santa Maud, Bzowski è un sedicente “collagista del suono” il cui lavoro sfuma il confine tra musica e sound design. Il suo uso di sintetizzatori lamentosi, percussioni martoriate e metodi di registrazione non convenzionali crea un’esperienza uditiva profondamente inquietante. Questa decisione curatoriale suggerisce che i registi vedano la precarietà economica come una forma di orrore in sé; la colonna sonora diventa la manifestazione uditiva dell’ansia di Lynette, il suono dei muri che si stringono.
Un ensemble di mondi volatili e vissuti
Mentre la performance di Kirby è l’innegabile centro di gravità del film, l’autenticità della narrazione è fortificata da un cast corale che popola l’odissea di Lynette con una serie di mondi volatili e vissuti. L’approccio dichiarato di Caron era quello di garantire che ogni personaggio, da Stephan James e Julia Fox a Randall Park ed Eli Roth, sembrasse il protagonista della propria storia. Due interpretazioni forniscono una zavorra cruciale. Zack Gottsagen offre una performance calda e commovente nei panni di Kenny, il fratello di Lynette e il cuore emotivo del film, incarnando il futuro che lei sta lottando per proteggere. L’altro ruolo cardine appartiene a Jennifer Jason Leigh nei panni di Doreen, la madre il cui tradimento innesca la trama. Il ritratto dinamico di Leigh è tutt’altro che una semplice malvagità; le sue azioni sono presentate come il prodotto della sua stessa storia amareggiata. Il casting è un atto di profonda risonanza intertestuale. La celebre filmografia di Leigh è popolata da iconiche interpretazioni di donne vulnerabili e danneggiate in film come Ultima fermata Brooklyn e Georgia. La sua presenza importa questa storia cinematografica, suggerendo che Doreen sia una ex Lynette, una donna la cui lotta si è inasprita fino a diventare risentimento. Questa dinamica straziante diventa uno studio sul trauma generazionale, approfondendo la narrazione raccontando la storia dei decenni precedenti all’inizio del film.
Il prezzo del sogno americano
In ultima analisi, La notte arriva sempre trascende le sue meccaniche di genere per offrire una critica sociale potente e profondamente risonante. È, come ha notato Kirby, un riflesso di un’epoca in cui così tante persone vengono spinte al limite. Il film dà un volto alla difficile situazione di coloro che si trovano ai margini, usando la sua narrazione propulsiva per porre domande difficili: Qual è il vero prezzo della gentrificazione? Fino a che punto siamo disposti a spingerci per realizzare il sogno americano? E quel sogno è ancora raggiungibile per chi vive ai margini della società, o è diventato una promessa vana? È un ritratto straziante ed essenziale della lotta di una donna per un posto da chiamare casa in un mondo che sembra determinato a lasciarla fuori al freddo.
Il film è distribuito da Netflix ed è uscito il 15 agosto 2025.